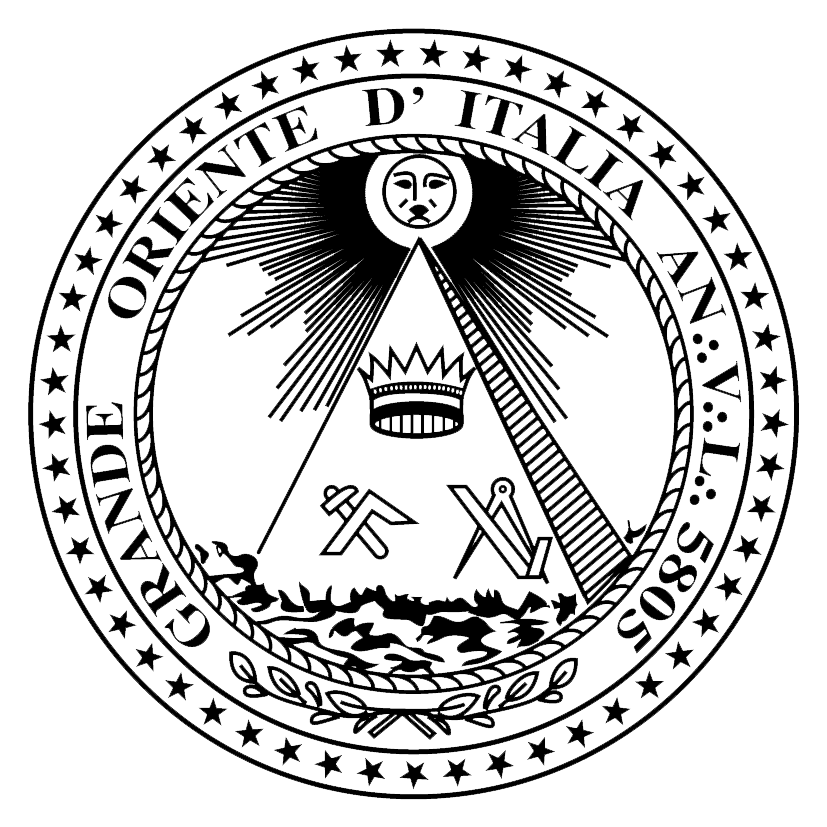La testimonianza di Nedo Fiano, matricola A5405 nel campo di sterminio di Auschwitz, scrittore, Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia e una lettera del massone Lionello Alatri deportato il 18 ottobre 1943
Nei campi di concentramento nazisti trovarono la morte 3 milioni di ebrei – tra i fucilati e quanti furono uccisi nei ghetti questa cifra sale a 6 milioni- 3.300 mila prigionieri di guerra , un milione di oppositori politici, 500 mila Rom, 9 mila omosessuali, 2250 testimoni di Geova, 270 mila tra disabili e malati di mente. Numerose le vittime anche tra i massoni: la stima, approssimativa perché non completamente esaminata a livello internazionale, si aggira intorno a 80 mila.
Per non dimenticare quella che è stata la più immane tragedia dell’umanità il 20 luglio del 2000 venne istituita per legge il Giorno della Memoria con la seguente motivazione: « La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.»
Nedo Fiano “Oggi vi racconterò l’inferno”
Attenzione, io vi racconterò l’inferno. Non sto scherzando. Ho sofferto molto questo incontro, come sempre quando sono davanti alla generazione che è venuta dopo quell’inferno.
Questa non è una lezione, ma la lezione! Non perché la faccio io, ma perché è una lezione che viene da molto lontano. Unica.
Ero come voi, esattamente come voi, sorridevo come voi, pensavo e ridevo delle cose più tremende, perché il sorriso è il dono della vostra età.
Avevo 18 anni quando sono stato arrestato e non avevo fatto nulla, non avevo assolutamente nessuna colpa, credevo nella vita, credevo nella famiglia, nei genitori e nel mio futuro. Sono stato messo in carcere, ho vissuto in carcere senza colpa, senza sapere quando mi avrebbero tirato fuori. Dal carcere sono stato portato al campo di concentramento, e dal campo di concentramento sono stato deportato al campo di sterminio.
Ecco perché oggi vi racconterò l’inferno. Non vi parlerò del campo di concentramento ma del campo di sterminio, da cui non si può uscire vivi, né morti, perché dal campo può uscire solo l’anima, perché tu «uscirai dal camino».
Fu un arresto tragico: io passeggiavo per una via di Firenze e qualcuno mi mise una pistola al fianco e mi disse «Tu sei ebreo!» e cominciò da lì la mia storia.
Ma io non vi voglio parlare del carcere, non mi piace; il carcere appartiene ancora alle cose comprensibili, intelligibili; anche il campo di concentramento è un fatto comprensibile. Io vi voglio parlare del campo di sterminio, perché ve lo mettiate bene nella testa, perché il campo di sterminio è il fatto più drammatico, più incredibile, più tragico che l’uomo possa vivere, è un allontanamento progressivo dalla vita, è la distruzione interiore dell’uomo.
Avete visto questa casacca: è un lontano ricordo, vestivamo così per tutto l’anno, a 28 gradi sotto zero a Danzica, cotone a strisce, col numero tatuato sul braccio. Dunque vi parlerò di questo inferno, cosa era Auschwitz, sì, quello dell’«Arbeit macht frei». Auschwitz vuol dire soprattutto forni crematori, vuol dire la sicurezza quasi matematica di non arrivare a sera…, non a domani, a sera.
«Un pidocchio – la tua morte»: ogni 15 giorni i prigionieri venivano sottoposti ad un attento controllo e chi aveva un pidocchio veniva messo da una parte.
Dopo quattro ore era garantito cenere, né più né meno cenere, e tu sentivi la morte che ti scendeva dentro, ti sentivi svuotato, non eri più un uomo, eri già cadavere.
E il prigioniero si chiedeva: «Ma come si soffrirà? Quanto durerà la sofferenza, come si fa a morire, non è una fucilazione, verrò bruciato, verrò prima gasato e poi bruciato… dovrò soffrire venti minuti, mezz’ora, non so, come fanno?!!!».
Bene, per voi che studiate lingue, io ebbi la fortuna di parlare due lingue e mezzo e venni inquadrato in un Kommando, così si chiamava, che lavorava davanti ai forni crematori, dove i prigionieri venivano avviati all’arrivo.
Vi parlerò dei forni crematori, non vi parlerò delle razioni di pane, delle razioni di fame.
Vi parlerò dei forni crematori, dei quali quasi nessuno parla.
Ad Auschwitz gli ebrei non sono stati semplicemente uccisi, ma prima sono stati asfissiati e dopo sono stati bruciati. Non era poi una cosa così semplice.
Stranamente l’architettura di questa splendida aula mi ha ricordato qualcosa di drammatico: questo tetto con le luci intagliate nel cemento… Ebbene, l’eccidio cominciava dalla stazione con la selezione, di cui avrete probabilmente visto molte fotografìe, dove gli uomini erano separati dalle donne, i vecchi dai giovani. Si salvava, nella grande media, un 15 per cento dei prigionieri in arrivo, che sedicenti medici avevano giudicato validi per il campo di lavoro; quelli che non andavano nel campo di lavoro, venivano avviati ai forni crematori.
Voi direte: ma se andavano ai forni crematori buoni buoni, erano dei cretini, degli incapaci, dei vili. Come si possono definire?
La risposta è una sola: nessuno sapeva che andava a morire. Nessuno sapeva dell’esistenza dei forni crematori. Nessuno!!!
Quando noi li abbiamo visti per la prima volta, credevamo che fossero le ciminiere delle fabbriche, dove saremmo andati a lavorare per il grande Terzo Reich; invece erano i luoghi dove si bruciavano i cadaveri.
Una prima sala che grosso modo sarà stata 1/6 di questa, col soffitto alto 3-4 metri, con l’etichetta illusoria di «Sala di disinfezione», era la sala nella quale venivano ammassati i prigionieri nudi, dopo essere stati invitati a depositare in ordine i loro abiti, le loro scarpe ed ogni altra cosa in loro possesso («Mettete le vostre scarpe bene in ordine, la sinistra allacciata con la destra, in modo da ritrovarle dopo la disinfezione!!»).
Con qualche vaga apprensione, le povere vittime entravano in quella dannata sala, tutta schizzata di sangue, con iscrizioni fatte non so come e lì venivano chiusi.
Dopo un po’ dal soffitto venivano introdotti, per mano di un sottufficiale tedesco (un uomo che io vedevo quasi quotidianamente, un vero Caronte) i cristalli di Cyclon B che, con la temperatura molto elevata che veniva prodotta dalle vittime ammucchiate, esalavano un gas venefico che dava la morte.
Immaginate 300-400 persone ammassate in una sala, dopo viaggi di 7 giorni e 7 notti, sospinte dentro, ignare di quello che accadrà loro, e che sentono arrivare lentamente la morte, con i bambini in braccio, con i genitori vecchi accanto, uomini e donne nella più totale promiscuità… Spesso morivano di asfissia perché era esaurito il Cyclon B; con dolori atroci si contorcevano e cercavano di guadagnare in qualche maniera un’invisibile uscita per la vita con i loro figli che morivano nelle braccia, o coi genitori che disperatamente gridavano «aiuto, aiuto!!!».
Nessuno sentiva niente e nessuno vedeva niente; c’era uno spioncino dal quale il graduato nazista vedeva cosa stesse accadendo e aspettava che tutti fossero morti.
Quando, dopo 15-20 minuti, talvolta anche di più, questa maledetta sala veniva riaperta, lo spettacolo era spaventoso. C’erano centinaia di cadaveri avvinghiati l’uno con l’altro negli escrementi, nel sangue, nelle urine; una squadra speciale, il Sonderkommando, doveva prendere ad uno ad uno questi prigionieri, tagliare loro i capelli, fare delle esplorazioni anali e vaginali per vedere se avessero nascosto gioielli o preziosi, e poi estraevano loro i denti d’oro. C’era una grande cassa di legno dove venivano raccolti tutti i valori recuperati.
I cadaveri venivano poi distesi su delle lettighe, spesso a martellate perché erano in tutte le posizioni, venivano portati con gli ascensori ai forni crematori e lì bruciati.
Nel periodo che va dal giugno all’agosto 1944 nel campo di Birkenau sono state gasate e bruciate più di 10 mila persone al giorno. In quei mesi è stata fra l’altro sterminata in larga misura tutta la comunità ebraica ungherese.
Nel campo di Auschwitz la più piccola infrazione veniva punita con 25 nerbate sui glutei o sui polpastrelli e se il punito non era capace di contare fino a 25 in tedesco, il Kapo ricominciava a contare fino alla morte del prigioniero.
La morte era lo scopo unico di questo campo. Immaginate che cosa vuol dire vivere in un campo dove si bruciano 10 mila persone al giorno, col fetore di carne bruciata che perseguitava giorno e notte.
Pensate ai prigionieri di Auschwitz che conoscevano il destino dei loro genitori, delle loro mogli, dei loro figli, dei loro parenti. In quel campo ho perso tutta la mia famiglia – dieci persone: mio padre, mia madre, mio fratello con la moglie e con un bambino di un anno e mezzo, mia nonna, mia zia, mio zio con due figli. E per questo, soltanto per questa ragione che io sono qui a parlarvi. Faccio un grande sforzo per non piangere, perché questa ferita la porto nel cuore e nel corpo per tutta la vita; ma al di là della sofferenza, c’è il dovere di raccontare, di dire che cosa è accaduto per insegnarlo, perché da quell’inferno viene appunto il grande insegnamento che la libertà è nelle mani di ognuno e ogni uomo ha il diritto-dovere di difendere la propria libertà e la libertà degli altri.
Nel campo di Auschwitz c’erano anche cose che definire ridicole è poco. Erano piuttosto insultanti.
Ad esempio nelle baracche c’era scritto «Sei immer kamarade» (Sii sempre camerata), «Sei immer höflich» (Sii sempre gentile), come se in quelle condizioni subumane gli uomini avessero la possibilità di comportarsi normalmente. Vi voglio parlare della piazza d’appello di Auschwitz: i prigionieri si alzavano alle quattro del mattino per poter uscire alle sette nei vari Kommandos fuori del campo; in quella piazza d’appello, che neppure Dante avrebbe potuto immaginare altrettanto tragica, i prigionieri passavano due o tre ore, anche più, fino a che «la conta» non quadrava.
Sotto la neve, la pioggia, le nerbate, la fame e la paura, unicamente per avere il diritto di uscire a lavorare per prendere un’altra dose di nerbate, i prigionieri dovevano stare rigidi, immobili. In questa piazza migliaia di uomini in fila in una geometria terrificante, disumana, nella posizione di attenti, senza cappello, in qualunque condizione di tempo, sani, malati, vecchi, giovani, senza eccezione perché le eccezioni erano punite con la morte. Non un uomo, fra 150 mila, osava fare il più piccolo movimento. Era quello il momento sacro della disciplina germanica, dell’ordine, della ferocia di trasformare gli uomini in macchine, in robot, era la distruzione dell’umano, la creazione di un uomo che non è più uomo, la personificazione della paura. Noi che ci siamo passati dentro non possiamo rinunciare a portarvene la testimonianza. Forse avrete visto in qualche filmato l’orchestra del campo. Ma l’orchestra del campo di Auschwitz era un modello di pulizia, di ordine, di allineamento, non c’erano volti affamati. Suonava musiche che io porto ancora dentro di me, alcune erano dolci, altre feroci, con un ritmo che se non lo rispettavi eri morto. Ti agguantavano con ferocia, ti alzavano la manica sinistra, annotavano il tuo numero e dopo quattro ore eri cenere. Chi aveva male ai piedi, chi aveva perduto gli occhiali, chi aveva freddo, chi era febbricitante, doveva comunque marciare al passo, preciso, allineato, altrimenti era ucciso.
Arrivati sul posto di lavoro, c’erano generose dosi di nerbate per chi non riusciva ad impossessarsi degli attrezzi entro due o tre minuti. Nerbate! In qualunque condizione di tempo, i prigionieri di Auschwitz hanno spianato delle colline per ricrearle a 500 metri di distanza e viceversa, all’infinito; supplizi di ogni tipo con la fame, con la sete, col pensiero della famiglia. Il prigioniero di guerra e anche il prigioniero politico pensavano alla mamma, alla moglie, ai figli e sapevano che se fossero ritornati avrebbero ritrovato i loro cari: noi sapevamo che non saremmo ritornati, ma che se anche fossimo riusciti a tornare, non avremmo trovato nessuno. Questa è stata la terribile perfidia nazista.
Se i prigionieri, in qualunque condizione di tempo, in qualunque posizione, al passaggio di una guardia, di una sentinella, dell’ultimo dei soldati, non si toglievano immediatamente il berretto, erano uccisi, anche se lo facevano in ritardo. All’arrivo abbiamo passato un giorno intero per imparare come ci si toglieva il berretto, con quale movimento teutonico bisognava togliere il berretto di fronte ad un rappresentante della «Herren Rasse», cioè alla «razza dei signori».
Noi non eravamo più niente, noi non esistevamo, eravamo stati annientati nel nostro essere più profondo, eravamo soltanto alla ricerca disperata di mangiare, di riposare, di metterci al riparo. All’ospedale, ogni dieci giorni, veniva fatta una selezione e i malati più gravi venivano inviati al forno crematorio.
Si è parlato di padre Kolbe qua dentro: ebbene io voglio dirvi con parole non mie che cosa significava finire nel carcere di Auschwitz; aprite bene le orecchie: «Erano condannati a morire di fame, il mio amico Kurt morì nella cella vicina dopo 15 giorni, alla fine si mangiò le scarpe, morì il 14 gennaio 1943. Me ne ricordo, era il mio compleanno!». Chi era condannato al «canile», così si chiamava il «Bunkerblock», senza vitto, poteva gridare, imprecare, fino a che voleva, la porta non veniva più aperta. «Le prime cinque notti – dice Peter Weiss nell’Istruttoria -gridò forte, poi la fame cessò, è prevalsa la sete, gemeva, gridava, supplicava, beveva la propria urina, leccava i muri e il periodo della sete cessò, durò tredici giorni, poi dalla sua cella non si sentì più nulla. Ci vollero più di due settimane prima che morisse, dal canile i cadaveri si dovevano raschiare via con dei pali; questo nel carcere di Auschwitz». A questo ho pensato riferendomi a padre Kolbe.
Quando si parla di campi di sterminio, si deve fare molta attenzione, non sono quei campi di cui ci parla la cinematografia hollywoodiana, con molta, troppa superficialità.
Nel campo di Auschwitz è andata tutta l’Europa, dalla Norvegia alla Grecia, dalla Francia all’Italia, all’Ungheria, dalla Polonia alla Cecoslovacchia, alla Russia, alla Bulgaria. Tutta l’Europa occupata dai nazisti era diventata materia prima per la fabbrica della morte. Pensate un momento come un uomo di diciotto anni possa invecchiare a ritmo accelerato nel giro di pochi mesi, per non dire di pochi giorni.
Ma la tragedia era incominciata molto prima, nel 1938, quando uomini senza colpa sono stati cacciati dagli impieghi, dalle università, dall’esercito, trasformati in cittadini di serie B. Gli ebrei italiani nel 1938 non potevano avere la radio in casa, né il telefono, ne fare la villeggiatura al mare o in montagna, né entrare nelle biblioteche.
E dopo cinque anni di serie B gli ebrei sono passati in serie C con l’avvento della Repubblica di Salò e dell’occupazione germanica; così ci hanno abbandonato i compagni, con cui avevamo giocato, le persone che avevano vissuto nella nostra stessa casa.
Nel 1943, quasi cinquanta anni fa, siamo fuggiti dalle nostre case come ladri, senza aver rubato, senza aver commesso nessun reato, soltanto perché credevamo in un Dio diverso. Gli uomini danno a questo Dio i nomi più strani, ma Dio è uno solo.
Siamo fuggiti di casa mio padre, mia madre, mia nonna ed io e abbiamo cercato rifugio un po’ dovunque, abbiamo battuto a mille porte.
Molti amici dicevano: «Sì, è vero, lo so, ma io ho famiglia, c’è la legge che punisce chi ospita gli ebrei, c’è la pena di morte, come posso esporre la mia famiglia a questo rischio, non posso, prova dal Bianchi…». Vai dal Bianchi: «Ma sai qui… io ho la moglie che non sta bene, andate dal Rossi». E così dal Rossi,dal Verdi, dal Gialli, fino a che la trappola è scattata, ci hanno catturato e da un giorno all’altro siamo passati da un mondo a un altro e siamo entrati nell’inferno.
Voi mi direte: «Ma come si esce da quell’inferno? In quali condizioni?».
Io non voglio affliggervi parlandovi delle mie condizioni fisiche, dei miei 37 chili, del campo di Buchenwald dove sono stato liberato. Preferisco parlarvi delle condizioni interiori.
Un uomo, intanto, non esce più da «quel» campo. Un uomo è sempre là. Quando, entrando nella vostra scuola, ho visto il nome di Primo Levi, ho cominciato a piangere, e ho continuato fino a quando ho incominciato a parlare.
Appena liberato avvertii un bisogno inesprimibile di amore, un bisogno di comprendere e di dare, come sto facendo oggi con voi.
Tra qualche anno non ci saranno più persone che vi porteranno questa giacca o che vi daranno la propria testimonianza.
Nonostante quella disperata sofferenza, quelle aberranti condizioni, quando siamo usciti dal campo avevamo un gran bisogno di amore, un gran bisogno di ritornare ad essere quelli che eravamo stati, ma drammaticamente non è stato così perché non siamo più stati quelli che eravamo. Vi dirò con le parole estratte da una lettera dei condannati a morte della Resistenza: «Com’è difficile dire addio per sempre alla bellezza della vita! Anche se il cielo fosse di carta e gli oceani del mondo fossero pieni di inchiostro, non basterebbero per scrivere il mio dolore, per descrivere ciò che accade intorno a me».
Ecco il grande dramma del deportato: accorgersi che la lingua non basta più a descrivere quelle condizioni aberranti e rendere quel mondo percepibile, tangibile.
Vi ho portato questa casacca perché qualcuno, toccandola, senta qualche cosa di concreto di quel tempo lontano.
L’analisi dei sentimenti, che Primo Levi ha fatto in maniera sublime, è una capacità che pochi uomini hanno. E un privilegio dei poeti.
Molti di noi hanno portato dentro questa sofferenza, non sono stati capaci di tirarla fuori, altri invece hanno potuto farlo. Ma l’esperienza della deportazione, dei campi di sterminio, per assurdo che possa sembrare, è anche un miracoloso dono, per quelli che come me sono tornati, perché ci ha aiutato a dare alle cose una profondità, una geometria diversa da quella che si fa usualmente. Perché ci ha dato la capacità di individuare l’essenziale delle cose, di rifuggire dal particolare inutile.
Chi ha sofferto fa sua la sofferenza degli altri, sente un’affinità con chi soffre. Chi non ha mai sofferto non sa che cosa vuol dire soffrire.
Diceva Socrate: «Solo chi è stato schiavo può capire che cos’è la libertà».
Oggi è venuto da voi un uomo vecchio, provato, che vi ha raccontato la sua storia.
Il racconto di questa storia è un dono che io vi ho portato perché possiate meditarla e farne tesoro: io l’ho messa a vostra disposizione perché è stata una grande esperienza; l’umanità ha bisogno di amore, ma anche l’amore è difficile perché è difficile donare.
Una delle cose più grandi di cui l’uomo ha un bisogno insopprimibile è la libertà.
Voi che, negli anni prossimi, avrete in mano il mezzo per difendere questa libertà, ricordatevelo: voi e soltanto voi avrete i mezzi per difendere la vostra libertà e la libertà degli altri. Voi sarete responsabili di preservarla, perché voi e soltanto voi sarete i protagonisti della vita.
Non lasciate agli altri questo privilegio e leggete la Storia, cercate di capire cosa è successo e perché, e sappiate donare agli uomini quello che è il dono più bello: l’Amore. Vi invito a farlo, siate bravi, siate responsabili, siate protagonisti.
(tratto da “Voci della Shoah- Testimonianze per non dimenticare” La Nuova Italia Editrice)
Nedo Fiano – il racconto di un sopravvissuto a Auschwitz
Nedo Fiano e Rina Lattes rinascere grazie all’amore
L’ultima lettera di Lionello Alatri
Lionello Alatri, romano, ebreo, era un massone, della Loggia Loggia Lira e Spada di Roma.
Vicepresidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, il 18 ottobre 1943, con la moglie Evelina e il suocero novantunenne Eugenio Haim Chimichi, Alatri è condotto dai nazisti alla stazione Tiburtina e tutti insieme vengono caricati sui carri merci di un treno diretto ad Auschwitz. È in questo momento che, intuendo la drammaticità della situazione, scrive il suo ultimo biglietto, che getta poi dal vagone nella speranza che qualcuno lo raccolga (“Per umanità chiunque trovi la presente è pregato impostare la presente”). Arrivati ad Auschwitz II-Birkenau il 23 ottobre, Lionello, Evelina ed Eugenio Haim Chimichi sono riconosciuti inabili al lavoro e uccisi nella camera a gas. La lettera, trovata da un ferroviere vicino ai binari, perverrà a Renzo e Marco Alatri (i figli) attraverso la segretaria del padre.
18-10-43
Lunedì mattina.
Partiamo per la Germania io, mia moglie e
mio suocero e Annita avvertite nostro viaggiatore Mieli.
Date ogni fine mese £ 600 alla mia portiera
e £ 250 a Irma cui rimborserete anche gas e luce.
Fate leggere la presente alla Sig.ra Ermelinda.
Ignoro se la merce rimarrà requisita.
Se potremo venderla ricordatevi che i pezzi del
1º Blocco devono essere venduti proporzionalmente alla merce tipo.
Se potete fare il cambio alla Banca di Sicilia
fatelo chiamando il sig. Riccardo.
Partiamo con fortezza d’animo: certo
la compagnia di mio mio suocero in quelle condizioni
mi sgomenta.
Fatevi forza come ce la facciamo noi.
Un abbraccio a tutti
Lione
Dite al Barone che Ettore e Elda e la sua
cugina Lella è con noi. Dite a Riccardelli rappresentante che moglie e figli stanno bene con noi.
Dite a Buccellato che Vito e Via Flavia sta bene con noi
Avvertite Via Po 42 al portiere che l’Ingegnere sta bene con noi
Avvertite portiere Via Villa Albani 12 sorella e cognata bene con noi.
Avvertite portiere Via Vicenza 42 pellicciaia sta con noi.
Avvertite portiere Via Po 162 Lello e Silvia bene con noi
Avvertite portiere Corso Italia 106 Famiglia Di Veroli bene con noi
” ” Via [illeggibile] Raul bene con noi
” ” Via Sicilia 154 Clara bene
Per umanità chiunque trovi la presente è pregato impostare la presente