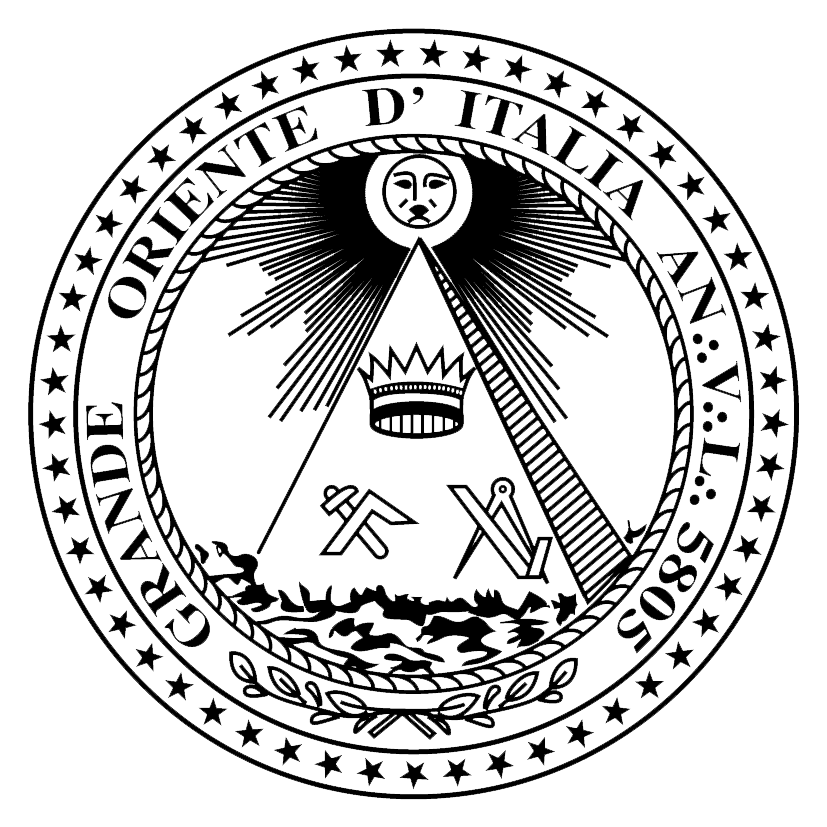Settembre 22, 2025

Dal Risorgimento alla laicità dello Stato, un anniversario che interpella la memoria collettiva
Ieri, 20 settembre, ricorreva l’evento della Breccia di Porta Pia. Un giorno che segna la fine del potere temporale dei papi e l’annessione di Roma al Regno d’Italia, eppure nell’immaginario collettivo pesa poco. Nonostante cerimonie ufficiali, discorsi commemorativi e la partecipazione di associazioni storiche e del Grande Oriente d’Italia, per molti italiani questa data resta un episodio lontano.
La Breccia di Porta Pia non è solo un evento militare: è un simbolo della nascita di Roma capitale, della costruzione dello Stato unitario e della laicità dello Stato.
Contiene però una componente controversa, la dimensione religiosa, perché sancì la fine del potere temporale dei papi. Per questo motivo, per decenni, partiti politici e istituzioni hanno preferito non enfatizzare la data e talvolta hanno parlato di “feste meno divisive”, un eufemismo che nasconde la complessità dell’evento.
La memoria storica
Durante il fascismo, la celebrazione fu cancellata ufficialmente. Senza festeggiamenti né trasmissione nelle scuole o nei media, la memoria collettiva si è affievolita. Nel dopoguerra, solo alcune istituzioni, associazioni culturali, gruppi di Bersaglieri e il Grande Oriente d’Italia hanno continuato a ricordarla come momento simbolico di libertà, cittadinanza e valori risorgimentali.
La richiesta di celebrare la data avanzata dal Grande Oriente d’Italia e dai Radicali contiene più di un fondo di verità. La Breccia di Porta Pia è radicata nelle stesse origini del Risorgimento italiano, nelle scelte che hanno segnato la costruzione dello Stato nazionale. Ripristinare la memoria di quel giorno significa ricordare le radici italiche, il coraggio di chi scelse libertà e unità e la tensione tra Stato e Chiesa che ha segnato la storia politica italiana.
Le celebrazioni odierne
Anche quest’anno, il 20 settembre è stato celebrato con iniziative a Roma. Il Grande Oriente d’Italia ha organizzato una cerimonia al Gianicolo e a Porta Pia, con deposizione di corone d’alloro e interventi del Gran Maestro Stefano Bisi, accompagnati da riflessioni sul Risorgimento e sulla laicità dello Stato. L’Associazione Nazionale Bersaglieri ha partecipato con parate e la tradizionale corsa dei labari, ricordando il valore militare e civile dei caduti. Diverse autorità locali hanno presenziato a momenti commemorativi sul Piazzale di Porta Pia. Associazioni culturali e storiche hanno promosso convegni, conferenze e visite guidate, coinvolgendo scuole e cittadini interessati alla storia del Risorgimento.
Queste celebrazioni mostrano come, pur non avendo lo stesso rilievo del 25 aprile o del 2 giugno, vi sia una rete di iniziative che ne preserva la memoria storica e i valori civili.
Il senso della memoria
Il 20 settembre resta così un giorno ricco di significato, pur non essendo una festa nazionale. La Breccia di Porta Pia è la storia di un’Italia che sceglie la libertà, la laicità e l’unità, un monito al coraggio e all’impegno civico. Ricordare questa data significa non solo celebrare un evento militare o politico, ma riaffermare le radici italiche del Risorgimento e la centralità dei valori civili che hanno costruito la nazione.
Il Risorgimento nel pensiero critico di Gramsci
Guardare alla Breccia di Porta Pia attraverso la lente del pensiero di Gramsci permette di cogliere la complessità del Risorgimento italiano. Per Gramsci, l’unità politica dell’Italia non fu accompagnata da una piena unità culturale e sociale. La nascita dello Stato moderno realizzò importanti conquiste, come l’abolizione dei residui feudali, l’unificazione amministrativa e la creazione di istituzioni moderne. Tuttavia, lasciò aperte tensioni profonde: forti disparità tra Nord e Sud, una borghesia liberale spesso debole e incapace di costruire un consenso ampio, e una coscienza nazionale ancora fragile tra le masse.
Questa visione non sminuisce il Risorgimento; al contrario, ne sottolinea il valore e il coraggio, riconoscendo i risultati concreti conseguiti. Allo stesso tempo, Gramsci ci invita a vedere i limiti strutturali e culturali che ne hanno impedito il compimento pieno, come l’assenza di un’egemonia culturale che coinvolgesse il popolo nella costruzione della nazione.
Applicare questo sguardo critico significa quindi apprezzare il Risorgimento nella sua interezza: riconoscere il coraggio dei protagonisti, l’importanza della Breccia di Porta Pia e dell’unità politica, ma anche comprendere le contraddizioni e le sfide sociali che rimasero aperte. È uno strumento prezioso per riflettere sull’Italia di oggi e sulle condizioni necessarie perché valori come libertà, cittadinanza e laicità continuino a essere patrimonio collettivo.
La Breccia di Porta Pia e l’Italia di oggi
Non sappiamo se il 20 settembre meriti di diventare una festa nazionale. Forse la risposta non è nelle celebrazioni ufficiali, ma nella capacità di trarne una riflessione sull’Italia contemporanea. La Breccia di Porta Pia non è solo un evento del passato: è un simbolo dei valori che hanno fondato lo Stato italiano e delle scelte coraggiose di chi volle libertà, unità e laicità.
Guardare a quella giornata significa chiedersi se l’Italia di oggi sia ancora capace di preservare quei valori. Siamo in grado di praticare coraggio civile, senso dello Stato, cittadinanza attiva e rispetto della diversità? Possiamo trarre dalla memoria del Risorgimento insegnamenti concreti per affrontare le sfide del presente: dalla coesione sociale alla partecipazione politica, dalla tutela dei diritti civili alla costruzione di un senso condiviso di comunità.
In questo senso, la Breccia di Porta Pia diventa più di un anniversario: è una lente per leggere il presente, un invito a interrogarsi sull’Italia che siamo e sull’Italia che vogliamo diventare. La memoria storica non serve solo a ricordare ciò che è stato, ma a capire cosa può ancora dire al nostro tempo, come stimolo a costruire un futuro consapevole e libero.