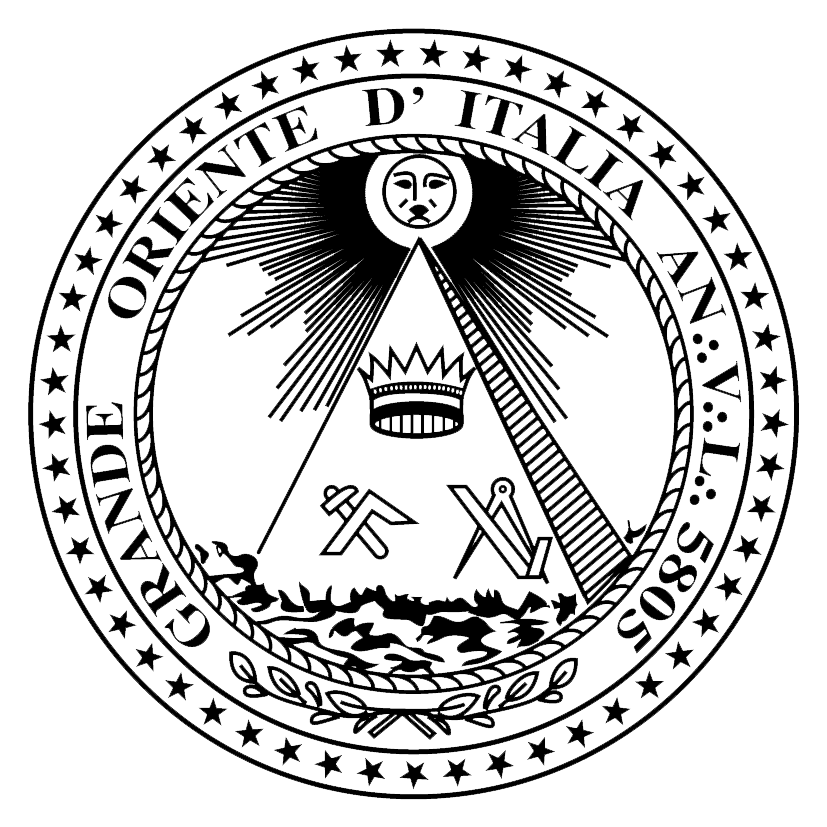Il Grande Oriente d’Italia ricorda Achille Ballori, il fratello martire ucciso a colpi di pistola nella serata del 31 ottobre del 1917 all’interno di Palazzo Giustiniani all’epoca sede della Comunione, da un folle, spinto a questo insano gesto dal clima fortemente antimassonico che cominciava a soffiare sull’ Italia, alla vigilia della marcia su Roma e dell’ascesa del fascismo, che perseguiterà i liberi muratori, mettendo a ferro e a fuoco le logge fino a sequestrare la sede del Goi. Nato a Dicomano (Pisa) il 29 aprile 1850, Ballori era un medico dalle straordinarie qualità. Aveva diretto l’ospedale civile di Mantova prima e poi gli Ospedali Riuniti di Roma e durante l’amministrazione di Ernesto Nathan era stato assessore all’Igiene della Capitale. Ineccepibile anche il suo curriculum massonico: nel 1874 era già maestro nella loggia Umanità e Progresso di Pisa e nel 1891 venerabile dell’officina Rienzi di Roma. Nel 1893 fu eletto Grande Maestro Aggiunto e alla vigilia del suo passaggio all’Oriente Eterno si accingeva a subentrare al Gran Maestro Ettore Ferrari, in procinto di dimettersi dall’incarico. Per sua volontà fu cremato e l’urna posta nel mausoleo dei Gran Maestri al Verano. Ballori era un personaggio noto e i media dell’epoca si occuparono molto del suo omicidio avvenuto lo stesso giorno della ritirata di Caporetto.
La cronaca dei fatti
Nel tardo pomeriggio del 31 ottobre del 1917, intorno alle 18,15 un uomo che si identifica come Giobbe Giobbi, sulla quarantina con pizzetto, abito grigio e cappello a lobbia, di media statura e robusto, suona il campanello del portone di Palazzo Giustiniani a Roma, dove ha sede il Goi, e chiede di parlare con Achille Ballori. Gli usceri lo fanno accomodare all’ingresso prima di annunciarne la presenza al Gma, che è nel suo ufficio in compagnia del Gran Segretario, il professor Ulisse Bacci. Giobbi fa irruzione nella stanza e chiede di restare da solo con Ballori. Impugna una rivoltella che punta contro il Gran Maestro Aggiunto. Ballori si rincantuccia in un angolo temendo di essere colpito, poi tenta di fuggire ma l’assassino apre il fuoco e gli spara contro quattro colpi per poi guadagnare lesto l’uscita nella confusione generale, fischiettando l’incipit della Cavalleria. Ballori soccorso da Bacci si accascia sul pavimento spirando. Dall’esame autoptico, eseguito all’Istituto di Medicina Legale in San Bartolomeo all’Isola, emergerà che la morte era stata causata da un proiettile penetrato attraverso la spalla fino al cuore. Giobbi lascia Palazzo Giustiniani, sale su un tram e alle 19,30 si presenta al n. 9 di via Augusto Valenziani, dove si trova l’abitazione del Gran Maestro uscente Ettore Ferrari, che però è fuori. Deve consegnargli del denaro, dice alla portiera, che lo invita a tornare il giorno successivo, e se ne va diretto, questa volta, a Palazzo Sciarra, che ospita la redazione del “Giornale d’Italia”. Qui ferma un fattorino al quale chiede come mai a quell’ora il quotidiano non era ancora uscito, sentendosi rispondere che il ritardo era dovuto all’annuncio dell’uccisione del professor Ballori.
Nel mirino anche Nathan
La Questura, intanto, immediatamente allertata dell’accaduto, aveva deciso di porre in sicurezza tutte le case dei massimi dirigenti della Massoneria, ed a ragione. Tant’è che il sedicente Giobbi verrà arrestato il giorno successivo verso le 15,30 da due poliziotti proprio mentre si aggirava in via Torino, nei pressi della residenza dell’ex Gran Maestro nonché ex sindaco di Roma Ernesto Nathan. Interrogato in strada dai due agenti in borghese, l’uomo esibisce il passaporto. E’ intestato a Lorenzo D’Ambrosio di anni 47, nato ad Avellino, domiciliato a Roma in via Carlo Alberto 63, di professione farmacista. Portato al commissariato vicino, viene perquisito. In tasca ha un coltello a serramanico “a foglia d’olivo” di 9 cm e un revolver Smith & Wesson a 5 colpi, calibro 7,65 scarico.
Il pregiudizio
Ai poliziotti che lo interrogano D’Ambrosio – alias Bacci- manifesta tutta la sua avversione psicotica nei confronti della Massoneria, che accusa delle peggiori nefandezza del mondo secondo un preciso canone persecutorio ossessivo e la considera colpevole del suo internamento nel manicomio di Nocera nel 1916, e di ogni altra avversità patita, a cominciare dalla morte, avvenuta in America, della sorella Costantina, asfissiata dalle esalazioni di gas illuminante per un rubinetto lasciato aperto. E’ deciso a vendicarsi. Ed era stato per questo motivo, che, uscito dall’ospedale psichiatrico della sua città, si era trasferito a Roma, dove aveva comprato una pistola e aveva rintracciato le abitazioni dei vertici del Grande Oriente, cominciando a pedinarle. Durante l’interrogatorio spiega che non aveva “ragione alcuna di speciale antipatia per il Ballori, persona di ottimo cuore e di grande onestà”, tant’è che aveva comprato persino dei fiori da deporre sulla sua tomba, e che la sua “intenzione era di colpire la Massoneria nelle sue personalità più rappresentative”. Nel corso dell’istruttoria il giudice Mosca, sospettando che fosse mentalmente malato, chiese una perizia psichiatrica dell’imputato, dalla quale risultò che D’Ambrosio era un “alienato criminale” affetto da “demenza paranoide”. Ai sensi dell’art. 46 del Codice Penale non fu possibile considerarlo imputabile, ma essendo la sua libertà “pericolosa a sé e agli altri” il magistrato ne ordinò il ricovero in manicomio
La caccia al massone Il caso Ballori anticipó le feroci persecuzioni alle quali sarebbero andati incontro i fratelli del Grande Oriente d’Italia. Esattamente tre anni dopo quell’omicidio, era il novembre 1921, con un documento approvato per acclamazione il congresso fondativo del pnf sancí la definitva incompatibilitá con la Libera Muratoria. Da quel momento si aprí una una vera e propria caccia al massone e le camicie nere cominciarono a mettere a ferro e a fuoco le logge. Il giornale “Cremona Nuova”, controllato dal gerarca Roberto Farinacci, lanciò in questa circostanza anche un invito alle autorità ad entrare in possesso degli elenchi dei nomi dei massoni per “fucilarli in massa, come traditori della patria” mentre a Firenze il Direttorio del Fascio pubblicò un manifesto in cui si proclamava: “Noi dichiariamo guerra a questa associazione di codardi e vogliamo fare il nostro dovere, liberare finalmente l’Italia da questi acerrimi nemici”. Una guerra che nell’estate e autunno del 1924 si allargò a macchia d’olio. Officine furono devastate a Torino, Pistoia, Lucca, Livorno, Siena, Firenze, Bari ed Ancona. E poi Venezia, dove gli arredi sequestrati nei templi vennero esposti nella casa del fascio. Lo stesso accadde a Roma, Milano e Palermo. Si scatenò un’ondata di violenze che culminò il 31 ottobre di quell’ anno nell’assalto, il primo, a Palazzo Giustiniani. ( Tratto da Erasmo n 9 ottobre 2025)