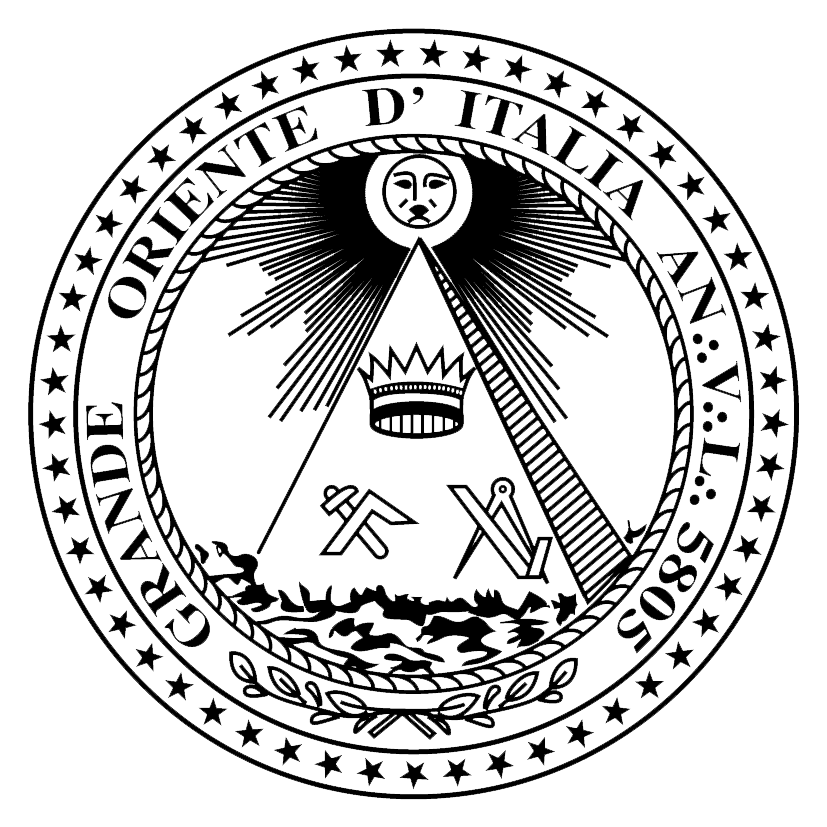di GIUSEPPE GANGEMI
Giambattista Vico è il grande illuminista degli inizi e Gaetano Filangieri è il grande illuminista della maturità dell’illuminismo napoletano. Il legame ideale esistente tra Vico, Antonio Genovesi e Mario Pagano è intuibile dal fatto che tutti e tre hanno insegnato etica all’Università di Napoli, ognuno ispirato da chi lo ha preceduto. Gaetano Filangieri, giurista puro, ha ampiamente, e con entusiasmo, spesso manifestato la profondità del debito intellettuale che ha avuto con Vico. La cosa ci viene confermata da Johann Wolfgang Goethe, che ne scrive ne II viaggio in Italia: “Fin da principio [Filangieri] mi ha fatto conoscere un antico scrittore, della cui sapienza senza fondo questi moderni giuristi italiani vanno quanto mai lieti e superbi. Il suo nome è Giambattista Vico, e lo antepongono al Montesquieu” (Goethe 2010, 212). Ponendo l’accenno su Montesquieu, Goethe, di fatto, riconosce che l’illuminismo di Filangieri trae poca ispirazione da quello francese. Ciononostante, dopo il 1799 si è cominciato a sostenere il contrario. Eleonora Fonseca Pimentel (Monitore Napolitano numero 8) è la prima a dichiarare che, se fosse stato vivo, sarebbe stato dalla parte della rivoluzione napoletana, sia perché i suoi scritti sono diventati vessilli di questa, sia perché era massone (“iscritto a società chiuse ai profani”). E, in effetti, è innegabile che questi scritti siano continuamente ribaditi dalla retorica rivoluzionaria. Rimane il dubbio se quei principi abbiano servito da guida alle concrete pratiche di azione politica giacobina. Poiché Filangieri è morto un anno prima della Rivoluzione Francese, non è facile capire come si sarebbe posto nei confronti di questa. Che ne abbia influenzato le dichiarazioni dei principi (la proclamazione dei diritti umani, i principi di libertà, uguaglianza e fraternità) è certo, coane pure che abbia influenzato la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Quello che rimane dubbio è se avrebbe accettato l’applicazione pratica, intollerante e violenta, che i Giacobini hanno fatto di quei principi. Molti studiosi contemporanei, con tono asseverativo, sostengono che sia i Giacobini francesi, sia quelli napoletani hanno servito, anche nella pratica, gli ideali di Filangieri. Non entro nel merito dell’esperienza francese. Mi soffermo sulla rivoluzione giacobina napoletana cui mi sembra di poter rimproverare una completa mancanza di senso della storia. Lo si è visto, per esempio, nella riforma più importante di tutte: l’abolizione della feudalità. C’è una differenza abissale tra la lucida azione di Domenico Caracciolo, purtroppo bloccata dal sovrano, e quella dei Giacobini, che non hanno la scusa dell’opposizione del Re. Filangeri ha inutilmente cercato di avvertire che ogni azione riformatrice si debba fare tanto più guardinga e gradualista quanto più si ripercuote profondamente sull’equilibrio sociale. Questo gradualismo è del tutto assente dall’azione dei Giacobini formatesi nelle logge massoniche del tempo. Detto questo, chiarisco che ho apprezzato una recente pubblicazione di Michele Drosi (Gaetano Filangieri. Riformista e garantista) che invita a centrare l’attenzione su un cenacolo di studiosi e sulle idee dei più noti che vi dibattono. Drosi invita a rileggere Filangieri centrando l’attenzione sull’originale sintesi del pensiero degli studiosi che collaborano al cenacolo: “Sotto l’influenza del genio di Vico e del pragmatismo di Genovesi, il giovane nobile Filangieri …” matura l’idea che gli ideali si valutano dalla pratica delle istituzioni perché “la pratica del foro [vale] molto più della scienza giuridica vera e propria” (Drosi 2025, 44). Trovo che questa chiave di lettura di Filangieri proposta da Drosi è più interessante delle letture accademiche che sono offerte dagli accademici di Venezia, Padova, Torino, etc. Il senso della storia, che è mancato nei Giacobini napoletani, secondo Drosi, Filangieri lo coltiva nelle discussioni con quei letterati che si riuniscono, fino al 1784, nella casa di campagna napoletana di Francescantonio Grimaldi. I più noti appartenenti a questo gruppo di discussione sono: il padrone di casa, Francesco Mario Pagano, Francesco Saverio Salti (Gioffrè in Drosi 1 / 3 Pagina Foglio 27-10-2025 12 www.ecostampa.it 105085 Quotidiano 2025, 4), cui vanno aggiunti “Melmaldi” (Drosi 2025, 78) e altri.
A parte Filangieri, nessuno di questi appartiene, al tempo, alla massoneria (Pagano vi aderirà nel 1784 e Salfi nel 1806, a Brescia, in un Regno d’Italia napoleonico e in un tempo in cui ormai la massoneria pratica più l’amalgama trasformista che la rivoluzione). Con l’esclusione di Pagano e Salfi, nessuno dei membri del cenacolo parteciperà alla Rivoluzione Giacobina napoletana. Da notare, il fatto che, in quella coterie, non tutti la pensano allo stesso modo: per esempio, sul tema dell’uguaglianza tra gli uomini, Grimaldi la nega e ritiene giusto la politica debba mantenere la naturale ineguaglianza della società, mentre Filangeri, Pagano e Salfi sono di tutt’altro parere. Su una cosa i frequentatori abituali di casa Grimaldi concordano: condividono l’interpretazione gradualista e pragmatica che, insieme a Filangieri, hanno appreso dalla lettura congiunta di Vico e Genovesi. L’illuminismo dei frequentatori di questo cenacolo differisce dalle posizioni dei Giacobini napoletani in più punti cruciali: gli ospiti di Grimaldi si ispirano di più agli illuministi napoletani e di meno a quelli francesi verso cui sono decisamente critici; i Giacobini si ispirano invece al pensiero illuminista francese e agli scritti di Pietro Giannone. Occorrerebbe approfondire cosa scelgono di fare i protagonisti del cenacolo quando, nel 1796, due decisioni dei sovrani si ripercuotono tragicamente sulle loro vite: 1) Pagano viene imprigionato per 26 mesi e poi liberato perché non si trovano prove di alcuna sua azione sovversiva. Quando ne esce, è decisamente cambiato. Fugge a Roma e a Milano e da qui tornerà pronto a collaborare alla Repubblica giacobina; 2) la vedova di Gaetano Filangieri, Charlotte Filangieri Frendel, si preoccupa di come le cose stiano cambiando intorno a sé e alla propria famiglia e agisce di conseguenza: “La Giunta di Stato, … a,pr [e] un provvedimento penale contro l’opera … di Filangieri … Si [va] sempre più delineando l’identificazione tra i suoi seguaci e gli ideali rivoluzionari … si [vede] in Filangieri uno dei padri della Rivoluzione francese. A seguito della repressione dei moti del 1799 …, Charlotte … [ripara, con i figli,] a Milano e avventurosamente arriva[no] in Francia” (Drosi 2025, 41).